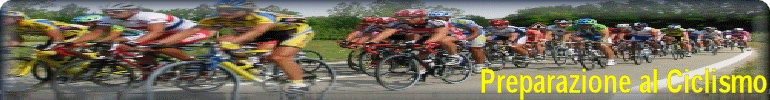
Lo Sport del Ciclismo
Specialit�
 Le
corse possono svolgersi su strada, su pista o su percorsi accidentati di
campagna (ciclocross). Le attivit� agonistiche su strada si suddividono in gare
in linea, a tappe e a cronometro. Le gare in linea, in cui i partecipanti
partono in gruppo, si concludono con l'arrivo al traguardo dei ciclisti che
hanno coperto il percorso o, nel caso di corse in circuito, pi� volte lo stesso
percorso. In generale la distanza massima da percorrere in una corsa in linea va
dai 150 chilometri, per i dilettanti, ai 240 chilometri, per i professionisti.
Le gare a tappe si svolgono nel corso di pi� giornate successive su un percorso
totale che arriva, per i grandi giri nazionali, a superare i 4000 chilometri; il
tempo impiegato da ciascun concorrente nelle singole frazioni viene sommato di
giorno in giorno fino a costituire la classifica generale che alla fine della
manifestazione proclamer� vincitore chi ha impiegato il minor tempo per coprire
il chilometraggio complessivo. Alcune tappe possono essere a cronometro: i
ciclisti, che non partono in gruppo ma scaglionati a intervalli di qualche
minuto, sono impegnati in una gara contro il tempo. Le corse a cronometro,
perlopi� individuali, ma talvolta anche a squadre, possono svolgersi su un
percorso pianeggiante, oppure in salita; in tal caso, vengono definite "cronoscalate".
Le
corse possono svolgersi su strada, su pista o su percorsi accidentati di
campagna (ciclocross). Le attivit� agonistiche su strada si suddividono in gare
in linea, a tappe e a cronometro. Le gare in linea, in cui i partecipanti
partono in gruppo, si concludono con l'arrivo al traguardo dei ciclisti che
hanno coperto il percorso o, nel caso di corse in circuito, pi� volte lo stesso
percorso. In generale la distanza massima da percorrere in una corsa in linea va
dai 150 chilometri, per i dilettanti, ai 240 chilometri, per i professionisti.
Le gare a tappe si svolgono nel corso di pi� giornate successive su un percorso
totale che arriva, per i grandi giri nazionali, a superare i 4000 chilometri; il
tempo impiegato da ciascun concorrente nelle singole frazioni viene sommato di
giorno in giorno fino a costituire la classifica generale che alla fine della
manifestazione proclamer� vincitore chi ha impiegato il minor tempo per coprire
il chilometraggio complessivo. Alcune tappe possono essere a cronometro: i
ciclisti, che non partono in gruppo ma scaglionati a intervalli di qualche
minuto, sono impegnati in una gara contro il tempo. Le corse a cronometro,
perlopi� individuali, ma talvolta anche a squadre, possono svolgersi su un
percorso pianeggiante, oppure in salita; in tal caso, vengono definite "cronoscalate".
 Le
gare su pista si disputano all'interno di un'apposita struttura, detta
velodromo, che pu� essere scoperta o coperta. Le principali specialit� in cui
i ciclisti � individualmente, a coppie o a squadre � si misurano sono la
velocit�, l'inseguimento e il mezzofondo al seguito di "allenatori
meccanici". Le gare di velocit� si svolgono tra due o pi� corridori sulla
distanza di mille metri; viene rilevato il tempo impiegato per percorrere gli
ultimi duecento metri. Mentre nella velocit� i ciclisti partono dallo stesso
punto della pista, nell'inseguimento, alla partenza, i due concorrenti si
trovano sui lati rettilinei opposti dell'ovale; il vincitore � quello che al
termine della gara ha guadagnato terreno sull'avversario, o che lo ha raggiunto
durante la corsa. La distanza nelle gare a inseguimento � di norma di cinque
chilometri per i professionisti e di quattro per i dilettanti. Cento chilometri
(o un'ora di durata) � invece la misura per il mezzofondo dietro motori:
l'"allenatore meccanico" � uno speciale mezzo a motore che precede il
ciclista e che, tagliando l'aria, gli permette di raggiungere velocit� molto
elevate.
Le
gare su pista si disputano all'interno di un'apposita struttura, detta
velodromo, che pu� essere scoperta o coperta. Le principali specialit� in cui
i ciclisti � individualmente, a coppie o a squadre � si misurano sono la
velocit�, l'inseguimento e il mezzofondo al seguito di "allenatori
meccanici". Le gare di velocit� si svolgono tra due o pi� corridori sulla
distanza di mille metri; viene rilevato il tempo impiegato per percorrere gli
ultimi duecento metri. Mentre nella velocit� i ciclisti partono dallo stesso
punto della pista, nell'inseguimento, alla partenza, i due concorrenti si
trovano sui lati rettilinei opposti dell'ovale; il vincitore � quello che al
termine della gara ha guadagnato terreno sull'avversario, o che lo ha raggiunto
durante la corsa. La distanza nelle gare a inseguimento � di norma di cinque
chilometri per i professionisti e di quattro per i dilettanti. Cento chilometri
(o un'ora di durata) � invece la misura per il mezzofondo dietro motori:
l'"allenatore meccanico" � uno speciale mezzo a motore che precede il
ciclista e che, tagliando l'aria, gli permette di raggiungere velocit� molto
elevate.
 Tra le
competizioni che si svolgono in pista esistono inoltre le gare a cronometro, le
corse a punti, le gare di velocit� in tandem. Tutte queste specialit� sono
comprese nelle "sei giorni", manifestazioni in cui gli atleti
partecipano in coppia, alternandosi nelle varie prove su un arco di tempo di
appunto sei giorni. Su pista si svolgono anche i tentativi di migliorare il
record dell'ora, in cui viene misurato il percorso che il ciclista riesce a
coprire in sessanta minuti.
Tra le
competizioni che si svolgono in pista esistono inoltre le gare a cronometro, le
corse a punti, le gare di velocit� in tandem. Tutte queste specialit� sono
comprese nelle "sei giorni", manifestazioni in cui gli atleti
partecipano in coppia, alternandosi nelle varie prove su un arco di tempo di
appunto sei giorni. Su pista si svolgono anche i tentativi di migliorare il
record dell'ora, in cui viene misurato il percorso che il ciclista riesce a
coprire in sessanta minuti.
Oltre che su strada e su pista, si tengono gare ciclistiche anche fuori strada. Il ciclocross, o corsa ciclocampestre, si svolge, prevalentemente in inverno, su un percorso di circa venticinque chilometri su terreno di campagna reso difficile dalla presenza di ostacoli naturali e artificiali. Altre specialit� fuori strada che si vanno affermando negli ultimi anni sono quelle che si praticano con le mountain bike e con le BMX: prove di velocit�, di discesa, di regolarit�, a cronometro e combinate.
Ogni specialit� ciclistica adotta un tipo diverso di bicicletta: dai leggerissimi telai in alluminio e fibra di carbonio, per la corsa su strada e su pista, a quelle molto robuste dotate di speciali copertoni e sospensioni per le prove di mountain bike. Mentre la bicicletta da ciclocross �, a parte le forcelle rinforzate, essenzialmente simile a quella da strada, pi� consistenti sono le differenze tra quest'ultima e la bicicletta da pista, che non possiede il meccanismo della ruota libera (il dispositivo che permette alla ruota di continuare la sua rotazione anche quando i pedali sono fermi o girano all'indietro) e non � dotato n� di cambio n� di freni. In tutte le specialit�, tranne che per i professionisti su strada, � obbligatorio l'uso del casco.
Storia
 Il
primo prototipo di bicicletta, il celerifero, fu presentato al Palais Royal nel
1791, ma per vedere la realizzazione della prima "vera" bicicletta
occorre attendere l'invenzione del velocipede, progettato e costruito nel 1861
dai francesi Pierre ed Ernest Michaud. La prima gara, su 1200 metri, si disput�
nel parco di Saint Cloud a Parigi, nel 1868, e il vincitore fu un inglese, James
Moore. In questo periodo si cominciarono a disputare in Francia le prime corse
su strada; l'Italia accolse ben presto il nuovo sport: nel 1870 si svolse la
prima gara importante, la Firenze-Pistoia, di 33 km, vinta dallo statunitense
Rynner van Hestet, e nello stesso anno si disput� il circuito dei bastioni
milanesi (11 km) vinto da Giuseppe Pasta in 37 minuti.
Il
primo prototipo di bicicletta, il celerifero, fu presentato al Palais Royal nel
1791, ma per vedere la realizzazione della prima "vera" bicicletta
occorre attendere l'invenzione del velocipede, progettato e costruito nel 1861
dai francesi Pierre ed Ernest Michaud. La prima gara, su 1200 metri, si disput�
nel parco di Saint Cloud a Parigi, nel 1868, e il vincitore fu un inglese, James
Moore. In questo periodo si cominciarono a disputare in Francia le prime corse
su strada; l'Italia accolse ben presto il nuovo sport: nel 1870 si svolse la
prima gara importante, la Firenze-Pistoia, di 33 km, vinta dallo statunitense
Rynner van Hestet, e nello stesso anno si disput� il circuito dei bastioni
milanesi (11 km) vinto da Giuseppe Pasta in 37 minuti.
Tra la fine del secolo e i primi anni del seguente gli appassionati del nuovo mezzo cominciarono in tutta Europa a fondare circoli e associazioni, organizzando manifestazioni e gare che hanno resistito per decenni diventando dei classici di questo sport. Gi� nella prima Olimpiade moderna (Atene 1896) la bicicletta era presente con varie specialit� (le gare femminili dovettero aspettare quasi un secolo; furono introdotte solo nel 1984). Nacquero a partire da questo periodo alcune delle corse su strada pi� rinomate: tra le gare a tappe il Tour de France (1903), il Giro di Lombardia (1905), il Giro d'Italia (1909, organizzato dalla "Gazzetta dello Sport"), il Giro delle Fiandre (1913), il Giro di Spagna (1935); tra le gare in linea la Liegi-Bastogne-Liegi (1892, la pi� antica delle "classiche" ancora oggi disputate), la Parigi-Roubaix e la Parigi-Tours (1896), la Milano-Sanremo (1907) e, pi� in l� negli anni, la Freccia Vallone (1936). Del 1927 � la prima edizione del campionato del mondo su strada.
 Nel
volgere di pochi decenni, la bicicletta si era trasformata da passatempo
aristocratico e vagamente stravagante in mezzo di trasporto di massa, in Italia
non meno che nel resto d'Europa; la stessa sorte aveva seguito il ciclismo
sportivo, specie quello su strada, che ormai poteva contendere al calcio il
primato della popolarit�. I campioni del ciclismo erano eroi popolari, veri e
propri miti delle due ruote, e tali sono rimasti alcuni nel ricordo. Se
personaggi come Ottavio Bottecchia, Costante Girardengo, Alfredo Binda e Learco
Guerra riportano agli anni Venti e Trenta, anni eroici del ciclismo, nomi come Gino
Bartali, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Hugo Koblet,
Louison Bobet e Charlie Gaul evocano terribili salite e fughe solitarie,
tubolari di ricambio a tracolla e gesti nobili sulle polverose strade d'Italia e
d'Europa che, uscite dalla catastrofe della seconda guerra mondiale, si andavano
faticosamente ricostruendo. La radio e il bianco e nero dei cinegiornali (e in
seguito della televisione) diffondevano le imprese leggendarie di questi
campioni: il pubblico si divideva in accesi e irriducibili schieramenti
(esemplare in Italia la rivalit� tra "coppiani" e "bartaliani"),
ma i valori messi in gioco erano chiari, comuni, comprensibili e accessibili: la
tenacia, l'impegno, il rispetto e il lavoro di squadra. Nel ciclismo, infatti,
al di l� delle mitologie personali dei singoli assi, fondamentale � il lavoro
della squadra, dal capitano al pi� umile gregario, che contribuisce
collettivamente al risultato, che si tratti della maglia rosa del Giro o di
quella gialla del Tour.
Nel
volgere di pochi decenni, la bicicletta si era trasformata da passatempo
aristocratico e vagamente stravagante in mezzo di trasporto di massa, in Italia
non meno che nel resto d'Europa; la stessa sorte aveva seguito il ciclismo
sportivo, specie quello su strada, che ormai poteva contendere al calcio il
primato della popolarit�. I campioni del ciclismo erano eroi popolari, veri e
propri miti delle due ruote, e tali sono rimasti alcuni nel ricordo. Se
personaggi come Ottavio Bottecchia, Costante Girardengo, Alfredo Binda e Learco
Guerra riportano agli anni Venti e Trenta, anni eroici del ciclismo, nomi come Gino
Bartali, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Hugo Koblet,
Louison Bobet e Charlie Gaul evocano terribili salite e fughe solitarie,
tubolari di ricambio a tracolla e gesti nobili sulle polverose strade d'Italia e
d'Europa che, uscite dalla catastrofe della seconda guerra mondiale, si andavano
faticosamente ricostruendo. La radio e il bianco e nero dei cinegiornali (e in
seguito della televisione) diffondevano le imprese leggendarie di questi
campioni: il pubblico si divideva in accesi e irriducibili schieramenti
(esemplare in Italia la rivalit� tra "coppiani" e "bartaliani"),
ma i valori messi in gioco erano chiari, comuni, comprensibili e accessibili: la
tenacia, l'impegno, il rispetto e il lavoro di squadra. Nel ciclismo, infatti,
al di l� delle mitologie personali dei singoli assi, fondamentale � il lavoro
della squadra, dal capitano al pi� umile gregario, che contribuisce
collettivamente al risultato, che si tratti della maglia rosa del Giro o di
quella gialla del Tour.  E
sono valori che questo sport ha sostanzialmente conservato nei decenni,
nonostante la crescente professionalizzazione degli atleti, sottoposti a sempre
pi� rigorosi programmi di preparazione fisica e mentale, e le innovazioni
tecniche che hanno trasformato le biciclette in avveniristici strumenti di
precisione; e bench� la sfrenata commercializzazione del settore e i sempre pi�
diffusi episodi di doping stiano negli ultimi anni gettando oscure ombre sulla
integrit� morale di questo sport. La macchina organizzativa del ciclismo ogni
anno richiama sulle strade, soprattutto europee, un esercito pittoresco, una
"carovana" di ciclisti, pubblico, giudici, allenatori, tecnici,
giornalisti, telecronisti, venditori, pubblicitari.
E
sono valori che questo sport ha sostanzialmente conservato nei decenni,
nonostante la crescente professionalizzazione degli atleti, sottoposti a sempre
pi� rigorosi programmi di preparazione fisica e mentale, e le innovazioni
tecniche che hanno trasformato le biciclette in avveniristici strumenti di
precisione; e bench� la sfrenata commercializzazione del settore e i sempre pi�
diffusi episodi di doping stiano negli ultimi anni gettando oscure ombre sulla
integrit� morale di questo sport. La macchina organizzativa del ciclismo ogni
anno richiama sulle strade, soprattutto europee, un esercito pittoresco, una
"carovana" di ciclisti, pubblico, giudici, allenatori, tecnici,
giornalisti, telecronisti, venditori, pubblicitari.
Si possono ricordare alcuni dei nomi che in tempi pi� recenti hanno fatto la storia del ciclismo: i belgi Eddy Merckx e Roger De Vlaeminck; i francesi Jacques Anquetil, Laurent Fignon e Bernard Hinault; l'irlandese Stephen Roche e lo statunitense Greg Lemond; lo spagnolo Miguel Indurain; e gli italiani Felice Gimondi, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci e Marco Pantani, per le corse su strada; Antonio Maspes e Sante Gaiardoni per le specialit� su pista. Maria Canins � stata una delle migliori cicliste italiane.
Nel nostro paese, l'attivit� ciclistica � rappresentata e organizzata dalla FCI (Federazione Ciclistica Italiana) mentre la federazione mondiale, creata nel 1900, � l'UCI (Union Ciclyste International).
I vari tipi di gare: generalit�
Le gare ciclistiche possono essere disputate con classifica individuale o a squadre; nelle gare individuali, tuttavia, i corridori, a eccezione degli isolati, fanno parte di squadre i cui componenti collaborano per propiziare il miglior piazzamento del pi� forte, in genere il capitano. Nel c. alcune federazioni nazionali, tra le quali l'italiana, adottano dal 1899 una rigida distinzione tra dilettanti e professionisti e tra le gare a essi riservate. I ciclisti dilettanti sono classificati come allievi quando non hanno superato i 18 anni, dilettanti junior se hanno superato i 18 anni, dilettanti senior se hanno superato i 24. Le gare ciclistiche si distinguono in gare disputate su strade normalmente destinate al traffico (c. su strada), in velodromi (c. su pista) e su percorsi di campagna (ciclocross o ciclo campestre).
 C.
su strada, comprende gare in linea, a tappe, a cronometro, su circuito . Le gare
si effettuano con qualsiasi tempo purch� i concorrenti presentatisi alla
partenza non siano meno di 10; per le gare con percorso tra 150 e 250 km deve
essere predisposto un servizio di rifornimento, due per le gare pi� lunghe .
Lungo il percorso sono disposti uno o pi� posti di controllo, contrassegnati da
uno striscione di tela verde; il traguardo di arrivo � segnalato da uno
striscione bianco. L'arrivo su strada deve avvenire su un rettilineo di almeno
300 m e largo 8 m; l'arrivo su pista � consentito solo se la pista misura pi�
di 300 m e ha ingresso agevole e curve sufficientemente ampie; il tempo di
ciascun corridore viene in genere registrato all'entrata in pista, ma i
corridori devono passare due volte sulla linea di traguardo. Le corse in linea
sono quelle in cui tutti i corridori partono da una stessa linea; vince il
corridore che giunge primo al traguardo. Generalmente le corse in linea sono di
150-180 km per i dilettanti, di 250-280 km per i professionisti. Le corse a
tappe sono gare su distanze molto lunghe (anche oltre 4000 km), suddivise in
frazioni (tappe) da disputarsi in giorni successivi. Nelle corse a tappe sono
previste due classifiche: una parziale, compilata per ogni tappa, e una
generale, costituita dalla somma dei tempi impiegati nelle singole tappe; in
talune corse si usa premiare il vincitore (o anche il secondo e il terzo
classificato) di tappa con abbuoni di tempo (naturalmente differenziati), in
genere da 10 a 20 secondi; talora vengono assegnati abbuoni anche a chi transita
per primo sotto traguardi parziali. Sono previste anche particolari classifiche
a punti (per premiare il miglior scalatore, il corridore che ha riportato pi�
vittorie in volata su traguardi intermedi, ecc.). Alcune tappe sono disputate a
cronometro o su circuito oppure, talvolta, dietro allenatori meccanici. Le corse
a cronometro sono quelle in cui i corridori partono dalla stessa linea ma
isolatamente, a intervalli in genere di 1-2 minuti; la lunghezza di tali gare �
sempre inferiore a 100 km e pu� svolgersi in piano, su percorsi misti e in
salita (cronoscalata); possono essere effettuate anche a squadre di 2 o pi�
corridori: in tal caso la distanza arriva a 100 km e il tempo viene calcolato
sull'ultimo componente della squadra giunto al traguardo (in genere nelle prove
a squadra per stilare la classifica non � necessario che arrivino tutti i
componenti di ciascuna squadra schierati alla partenza: cos�, p. es. nella 4�100
km dei giochi olimpici e dei campionati mondiali, cui partecipano squadre di
quattro elementi, a determinare il tempo della squadra � l'arrivo del terzo
elemento). Le corse su circuito si svolgono su percorso stradale ad anello
inferiore a 5 km da compiersi pi� volte con un minimo di 50 km per i dilettanti
e di 100 km per i professionisti. � C. su pista, comprende gare di velocit�,
di tandem, a inseguimento (individuale e a squadre), di mezzofondo dietro motori
(stayers), a cronometro su 1 km (con partenza da fermo o lanciati), a
eliminazione, all'americana, individuale, a traguardi; comprende anche le �sei
giorni� e i primati. Le gare si disputano in velodromo o in stadi con pista
ciclistica e dotati delle necessarie attrezzature .
C.
su strada, comprende gare in linea, a tappe, a cronometro, su circuito . Le gare
si effettuano con qualsiasi tempo purch� i concorrenti presentatisi alla
partenza non siano meno di 10; per le gare con percorso tra 150 e 250 km deve
essere predisposto un servizio di rifornimento, due per le gare pi� lunghe .
Lungo il percorso sono disposti uno o pi� posti di controllo, contrassegnati da
uno striscione di tela verde; il traguardo di arrivo � segnalato da uno
striscione bianco. L'arrivo su strada deve avvenire su un rettilineo di almeno
300 m e largo 8 m; l'arrivo su pista � consentito solo se la pista misura pi�
di 300 m e ha ingresso agevole e curve sufficientemente ampie; il tempo di
ciascun corridore viene in genere registrato all'entrata in pista, ma i
corridori devono passare due volte sulla linea di traguardo. Le corse in linea
sono quelle in cui tutti i corridori partono da una stessa linea; vince il
corridore che giunge primo al traguardo. Generalmente le corse in linea sono di
150-180 km per i dilettanti, di 250-280 km per i professionisti. Le corse a
tappe sono gare su distanze molto lunghe (anche oltre 4000 km), suddivise in
frazioni (tappe) da disputarsi in giorni successivi. Nelle corse a tappe sono
previste due classifiche: una parziale, compilata per ogni tappa, e una
generale, costituita dalla somma dei tempi impiegati nelle singole tappe; in
talune corse si usa premiare il vincitore (o anche il secondo e il terzo
classificato) di tappa con abbuoni di tempo (naturalmente differenziati), in
genere da 10 a 20 secondi; talora vengono assegnati abbuoni anche a chi transita
per primo sotto traguardi parziali. Sono previste anche particolari classifiche
a punti (per premiare il miglior scalatore, il corridore che ha riportato pi�
vittorie in volata su traguardi intermedi, ecc.). Alcune tappe sono disputate a
cronometro o su circuito oppure, talvolta, dietro allenatori meccanici. Le corse
a cronometro sono quelle in cui i corridori partono dalla stessa linea ma
isolatamente, a intervalli in genere di 1-2 minuti; la lunghezza di tali gare �
sempre inferiore a 100 km e pu� svolgersi in piano, su percorsi misti e in
salita (cronoscalata); possono essere effettuate anche a squadre di 2 o pi�
corridori: in tal caso la distanza arriva a 100 km e il tempo viene calcolato
sull'ultimo componente della squadra giunto al traguardo (in genere nelle prove
a squadra per stilare la classifica non � necessario che arrivino tutti i
componenti di ciascuna squadra schierati alla partenza: cos�, p. es. nella 4�100
km dei giochi olimpici e dei campionati mondiali, cui partecipano squadre di
quattro elementi, a determinare il tempo della squadra � l'arrivo del terzo
elemento). Le corse su circuito si svolgono su percorso stradale ad anello
inferiore a 5 km da compiersi pi� volte con un minimo di 50 km per i dilettanti
e di 100 km per i professionisti. � C. su pista, comprende gare di velocit�,
di tandem, a inseguimento (individuale e a squadre), di mezzofondo dietro motori
(stayers), a cronometro su 1 km (con partenza da fermo o lanciati), a
eliminazione, all'americana, individuale, a traguardi; comprende anche le �sei
giorni� e i primati. Le gare si disputano in velodromo o in stadi con pista
ciclistica e dotati delle necessarie attrezzature .  Durante
le prove i corridori non possono superarsi all'interno, a meno che l'altro
concorrente non scatti verso l'esterno; non devono staccare le mani dal
manubrio, salvo per segnalare un incidente meccanico; devono mantenere la
propria linea di marcia e possono portarsi su quella dell'avversario solo dopo
averlo superato di due volte la lunghezza della bicicletta; non possono prendere
alcun punto d'appoggio oltre quelli offerti dalla propria bicicletta; non
possono retrocedere. Le biciclette per le gare sono a ruota fissa, senza freni e
senza dadi a farfalla sui mozzi delle ruote. Le gare di velocit� si disputano
tra due o tre concorrenti in due prove con eventuale bella, su due giri di pista
(tre quando misuri meno di 333,33 m); viene estratto a sorte il concorrente che
deve condurre in testa il primo giro durante il quale non pu� fermarsi in
surplace, cosa che gli � invece consentita, per tentare di far passare avanti
l'avversario e poterne sfruttare la scia, durante il secondo giro. Il tempo
viene rilevato sugli ultimi 200 m. Generalmente le gare si articolano su
successive eliminazioni dirette (batterie, ottavi, quarti, semifinali, finale)
con eventuali recuperi (rep�chages), mediante altre prove eliminatorie, di
concorrenti battuti. Con le stesse modalit�, e sulla distanza di 1 km, si
svolgono gare di velocit� per tandem. Le gare a inseguimento sono disputate su
5 km (4 per i dilettanti); i concorrenti partono dal punto centrale degli
opposti rettilinei al colpo di pistola del direttore di gara e tentano di
guadagnare terreno sull'avversario; vince chi, al termine della distanza
fissata, ha ridotto il distacco dall'avversario; la gara viene interrotta quando
un corridore raggiunge l'altro. Oltre che individuali, le gare a inseguimento
possono essere a squadre di due corridori (quattro se dilettanti); se alla gara
partecipano individualmente tre o quattro concorrenti, questa prende il nome di
australiana. Le gare di mezzofondo dietro motori (stayers) si svolgono
generalmente per un'ora o su 100 km; ogni corridore deve gareggiare rimanendo
nella scia di una motocicletta (allenatore), munita di un rullo fissato alla
ruota posteriore, per sfruttarne al massimo il risucchio d'aria. La gara di 1 km
a cronometro consiste in una prova di velocit� individuale in cui ciascun
concorrente viene cronometrato sulla distanza di 1000 m; la partenza avviene da
fermo o dopo due o tre giri di avvio (partenza lanciata). La gara a eliminazione
comprende una serie di volate su traguardi fissati ogni 2-3 giri, a ciascuno dei
quali viene eliminato l'ultimo classificato: gli ultimi due concorrenti rimasti
si disputano la vittoria sul traguardo finale. La gara all'americana si disputa
a squadre composte di coppie di concorrenti che si alternano in corsa ogni 2-3
giri. Il corridore momentaneamente fuori corsa pedala lentamente lungo il bordo
interno della pista in attesa di dare il cambio al compagno di coppia. I singoli
concorrenti contribuiscono al punteggio della coppia con i punti guadagnati
nelle volate per i traguardi posti a ogni dato numero di giri. Il medesimo
computo a punti regola la gara individuale a traguardi. La sei giorni �, in
pratica, una gara all'americana in cui le coppie gareggiano per sei giorni
consecutivi con due periodi di riposo giornalieri; la classifica viene compilata
sulla base del numero di giri compiuto dalle coppie e, in caso di parit�, sulla
base dei punteggi conseguiti sui traguardi. Tuttavia non esiste un regolamento
fisso e ciascuna sei giorni adotta una propria formula. In pista si svolgono
anche i tentativi individuali per primati di velocit� su numerose distanze (5,
10, 15 km, ecc.) nonch� per il pi� prestigioso di tutti, il primato dell'ora,
che consiste nel percorrere, con partenza da fermo, la maggiore distanza
possibile in un'ora di corsa .
Durante
le prove i corridori non possono superarsi all'interno, a meno che l'altro
concorrente non scatti verso l'esterno; non devono staccare le mani dal
manubrio, salvo per segnalare un incidente meccanico; devono mantenere la
propria linea di marcia e possono portarsi su quella dell'avversario solo dopo
averlo superato di due volte la lunghezza della bicicletta; non possono prendere
alcun punto d'appoggio oltre quelli offerti dalla propria bicicletta; non
possono retrocedere. Le biciclette per le gare sono a ruota fissa, senza freni e
senza dadi a farfalla sui mozzi delle ruote. Le gare di velocit� si disputano
tra due o tre concorrenti in due prove con eventuale bella, su due giri di pista
(tre quando misuri meno di 333,33 m); viene estratto a sorte il concorrente che
deve condurre in testa il primo giro durante il quale non pu� fermarsi in
surplace, cosa che gli � invece consentita, per tentare di far passare avanti
l'avversario e poterne sfruttare la scia, durante il secondo giro. Il tempo
viene rilevato sugli ultimi 200 m. Generalmente le gare si articolano su
successive eliminazioni dirette (batterie, ottavi, quarti, semifinali, finale)
con eventuali recuperi (rep�chages), mediante altre prove eliminatorie, di
concorrenti battuti. Con le stesse modalit�, e sulla distanza di 1 km, si
svolgono gare di velocit� per tandem. Le gare a inseguimento sono disputate su
5 km (4 per i dilettanti); i concorrenti partono dal punto centrale degli
opposti rettilinei al colpo di pistola del direttore di gara e tentano di
guadagnare terreno sull'avversario; vince chi, al termine della distanza
fissata, ha ridotto il distacco dall'avversario; la gara viene interrotta quando
un corridore raggiunge l'altro. Oltre che individuali, le gare a inseguimento
possono essere a squadre di due corridori (quattro se dilettanti); se alla gara
partecipano individualmente tre o quattro concorrenti, questa prende il nome di
australiana. Le gare di mezzofondo dietro motori (stayers) si svolgono
generalmente per un'ora o su 100 km; ogni corridore deve gareggiare rimanendo
nella scia di una motocicletta (allenatore), munita di un rullo fissato alla
ruota posteriore, per sfruttarne al massimo il risucchio d'aria. La gara di 1 km
a cronometro consiste in una prova di velocit� individuale in cui ciascun
concorrente viene cronometrato sulla distanza di 1000 m; la partenza avviene da
fermo o dopo due o tre giri di avvio (partenza lanciata). La gara a eliminazione
comprende una serie di volate su traguardi fissati ogni 2-3 giri, a ciascuno dei
quali viene eliminato l'ultimo classificato: gli ultimi due concorrenti rimasti
si disputano la vittoria sul traguardo finale. La gara all'americana si disputa
a squadre composte di coppie di concorrenti che si alternano in corsa ogni 2-3
giri. Il corridore momentaneamente fuori corsa pedala lentamente lungo il bordo
interno della pista in attesa di dare il cambio al compagno di coppia. I singoli
concorrenti contribuiscono al punteggio della coppia con i punti guadagnati
nelle volate per i traguardi posti a ogni dato numero di giri. Il medesimo
computo a punti regola la gara individuale a traguardi. La sei giorni �, in
pratica, una gara all'americana in cui le coppie gareggiano per sei giorni
consecutivi con due periodi di riposo giornalieri; la classifica viene compilata
sulla base del numero di giri compiuto dalle coppie e, in caso di parit�, sulla
base dei punteggi conseguiti sui traguardi. Tuttavia non esiste un regolamento
fisso e ciascuna sei giorni adotta una propria formula. In pista si svolgono
anche i tentativi individuali per primati di velocit� su numerose distanze (5,
10, 15 km, ecc.) nonch� per il pi� prestigioso di tutti, il primato dell'ora,
che consiste nel percorrere, con partenza da fermo, la maggiore distanza
possibile in un'ora di corsa .  Attualmente
l'U.C.I. distingue i primati in due tabelle a seconda che le prove vengano
effettuate in impianti al livello del mare (in realt� fino a 600 m di quota) o
in altura (al di sopra dei 600 m). Oltre al c. maschile, un certo sviluppo ha
anche quello femminile, specie su pista, grazie alla sua inclusione nel
programma dei giochi olimpici: annualmente si disputano anche campionati
mondiali (corsa su strada, cronometro a squadre; su pista: velocit�,
inseguimenti, a punti); sono ufficialmente riconosciuti alcuni primati su pista
(5, 10, 20 km, ecc.) e il record dell'ora, attualmente detenuto dalla francese
Jeannie Longo con 43,588 km (Milano, 1986) e 46,353 km (Citt� di Messico,
1989). Il ciclocross* prevede gare, disputate generalmente nei mesi invernali,
su percorsi di campagna con classifica sempre a tempo. Cenni storiciIl c. � uno
sport nato e diffuso eminentemente in Europa . Le prime gare ciclistiche furono
disputate tra draisine intorno al 1820 e allineavano mezzi estremamente
rudimentali dando luogo pi� a manifestazioni folcloristiche che a competizioni
sportive. La prima corsa ciclistica ufficiale fu il Grand Prix d'Amiens che si
svolse, tra bicicli, nel 1865: la vinse il savoiardo J. Cavigneaux. Seguirono, a
partire dall'anno successivo, sempre pi� numerose, in Francia, le corse di
bicicli, anche se spesso come manifestazioni di contorno e con numeri
d'attrazione, come le gare di acrobazia. La prima delle corse classiche del c.
si disput�, ancora con bicicli, nel 1869: fu la Parigi-Rouen, vinta
dall'inglese James Moore. Allo stesso anno risalgono le prime corse in Germania,
in Gran Bretagna e in Italia, dove, a Padova, fu organizzata una corsa su pista
come finale di una riunione ippica e, a Udine, si corse sulla distanza di 2 km;
nel 1870 fu disputata la Firenze-Pistoia, prima gara su strada (33 km), vinta
dallo statunitense Rynner Van Heste, e venne costituito il Veloce Club Milano.
Questo organizz� un �campionato italiano�, lungo i �bastioni� di
Milano, per complessivi 11 km: vinse Giuseppe Pasta alla media di 17,832 km.
Seguirono la Milano-Novara (1872) e la Milano-Piacenza (1873), vinte dal
milanese Giuseppe Bagatti Valsecchi. Nel 1876 si disput� la prima classica
italiana, la Milano-Torino, vinta da Luigi Magretti su altri 13 concorrenti, a
una media inferiore ai 13 km/h. Intanto, verso la fine degli anni Ottanta, si
afferm� la bicicletta, facendo rapidamente scomparire i bicicli e favorendo la
diversificazione delle specialit�. Carlo Braida, nel 1888, stabil� e ritocc�
i primati del chilometro, del miglio e dei 10 km; nel 1891 si disputarono i
primi campionati italiani, con le specialit� su pista e su strada, vinte
ambedue da Antonio Robecchi. Nel 1893, durante un campionato mondiale indetto a
Chicago, lo statunitense Arthur Zimmermann conquist� i titoli di velocit� sul
miglio e di mezzofondo sui 10 km, mentre il sudafricano Laurens Meintijes
prevalse nel fondo di 100 km; sempre nel 1893, il francese Henri Desgrange
stabil� il primo primato dell'ora (35,325 km). Contemporaneamente iniziarono
corse su strada con tappe sempre pi� lunghe: nel 1894 la Parigi-Brest-Parigi
(vinta dal francese Charles Terrant) e la Bordeaux-Parigi (vinta dall'inglese
Donald Mills); nel 1896 si corsero per la prima volta la Bordeaux-Parigi-Tours e
la Parigi-Roubaix mentre, ripristinate le Olimpiadi, il c. vi fu ammesso con sei
specialit�. Nel frattempo l'organizzazione sportiva del c. prese consistenza
con la costituzione delle prime federazioni nazionali. In Italia, il 6 dicembre
1885 fu costituita a Pavia l'Unione Velocipedistica Italiana (U.V.I.) la cui
denominazione fu mutata, nel 1964, in Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.).
Nel 1892 fu costituita l'International Cyclist Association (I.C.A.),
trasformatasi nel 1900 in Union Cyclist International (U.C.I.) con compiti e
strutture di massimo organo direttivo del c. mondiale. Nel 1903 si corse la pi�
appassionante delle competizioni su strada, il Tour de France, gara
internazionale a tappe; nel 1906 fu ripresa la Parigi-Bruxelles (la prima
edizione, nel 1893, fu la prima corsa a varcare i confini statali); nel 1908
furono istituiti la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro del Belgio; nel 1911 il Giro
della Catalogna e nel 1913 il Giro delle Fiandre. Numerose anche in Italia le
nuove gare, a molte delle quali arrider� notevole fortuna: nel 1903, la
Milano-Torino (ripresa dopo il 1876); nel 1905, il Giro di Lombardia; nel 1906
il Giro del Piemonte e la Milano-Modena; nel 1907, la Milano-Sanremo, il Giro
del Veneto, il Giro dell'Emilia; nel 1909 il Giro d'Italia; nel 1910 il Giro di
Romagna; nel 1911 il Giro della Campania. La I guerra mondiale rallent�, senza
interromperla, l'attivit� ciclistica europea che riprese in pieno nel 1919.
Nuove corse, poi famose, si aggiunsero a quelle gi� affermate: la Tre Valli
Varesine e la Coppa Bernocchi nel 1919; il Giro della Provincia di Reggio di
Calabria nel 1920; il Giro di Toscana nel 1923; il Giro del Lazio, il Giro
dell'Appennino (divenuto in seguito Circuito dell'Appennino) e la Parigi-Nizza
nel 1933; il Giro di Spagna nel 1935; la Freccia Vallone nel 1936. Dal 1921 per
i dilettanti e dal 1927 per i professionisti si disput� annualmente il
Campionato del mondo su strada. Durante la II guerra mondiale fu organizzata una
nuova corsa nella neutrale Svizzera: il Giro dei Quattro Cantoni (1944). Nel
dopoguerra seguirono: il Gran Premio delle Nazioni di Parigi (a cronometro) nel
1945; il Gran Premio dell'Industria e Commercio a Prato nel 1946; la
Sassari-Cagliari nel 1948; il Trofeo Baracchi (a cronometro a coppie) a Bergamo
e il Giro del Ticino nel 1949; il Gran Premio Campari di Lugano (a cronometro)
nel 1950; il Giro di Sardegna nel 1958. Le corse ricordate, comprese quelle
affermatesi fin dai primordi del c., compongono attualmente il calendario della
stagione ciclistica internazionale.
Attualmente
l'U.C.I. distingue i primati in due tabelle a seconda che le prove vengano
effettuate in impianti al livello del mare (in realt� fino a 600 m di quota) o
in altura (al di sopra dei 600 m). Oltre al c. maschile, un certo sviluppo ha
anche quello femminile, specie su pista, grazie alla sua inclusione nel
programma dei giochi olimpici: annualmente si disputano anche campionati
mondiali (corsa su strada, cronometro a squadre; su pista: velocit�,
inseguimenti, a punti); sono ufficialmente riconosciuti alcuni primati su pista
(5, 10, 20 km, ecc.) e il record dell'ora, attualmente detenuto dalla francese
Jeannie Longo con 43,588 km (Milano, 1986) e 46,353 km (Citt� di Messico,
1989). Il ciclocross* prevede gare, disputate generalmente nei mesi invernali,
su percorsi di campagna con classifica sempre a tempo. Cenni storiciIl c. � uno
sport nato e diffuso eminentemente in Europa . Le prime gare ciclistiche furono
disputate tra draisine intorno al 1820 e allineavano mezzi estremamente
rudimentali dando luogo pi� a manifestazioni folcloristiche che a competizioni
sportive. La prima corsa ciclistica ufficiale fu il Grand Prix d'Amiens che si
svolse, tra bicicli, nel 1865: la vinse il savoiardo J. Cavigneaux. Seguirono, a
partire dall'anno successivo, sempre pi� numerose, in Francia, le corse di
bicicli, anche se spesso come manifestazioni di contorno e con numeri
d'attrazione, come le gare di acrobazia. La prima delle corse classiche del c.
si disput�, ancora con bicicli, nel 1869: fu la Parigi-Rouen, vinta
dall'inglese James Moore. Allo stesso anno risalgono le prime corse in Germania,
in Gran Bretagna e in Italia, dove, a Padova, fu organizzata una corsa su pista
come finale di una riunione ippica e, a Udine, si corse sulla distanza di 2 km;
nel 1870 fu disputata la Firenze-Pistoia, prima gara su strada (33 km), vinta
dallo statunitense Rynner Van Heste, e venne costituito il Veloce Club Milano.
Questo organizz� un �campionato italiano�, lungo i �bastioni� di
Milano, per complessivi 11 km: vinse Giuseppe Pasta alla media di 17,832 km.
Seguirono la Milano-Novara (1872) e la Milano-Piacenza (1873), vinte dal
milanese Giuseppe Bagatti Valsecchi. Nel 1876 si disput� la prima classica
italiana, la Milano-Torino, vinta da Luigi Magretti su altri 13 concorrenti, a
una media inferiore ai 13 km/h. Intanto, verso la fine degli anni Ottanta, si
afferm� la bicicletta, facendo rapidamente scomparire i bicicli e favorendo la
diversificazione delle specialit�. Carlo Braida, nel 1888, stabil� e ritocc�
i primati del chilometro, del miglio e dei 10 km; nel 1891 si disputarono i
primi campionati italiani, con le specialit� su pista e su strada, vinte
ambedue da Antonio Robecchi. Nel 1893, durante un campionato mondiale indetto a
Chicago, lo statunitense Arthur Zimmermann conquist� i titoli di velocit� sul
miglio e di mezzofondo sui 10 km, mentre il sudafricano Laurens Meintijes
prevalse nel fondo di 100 km; sempre nel 1893, il francese Henri Desgrange
stabil� il primo primato dell'ora (35,325 km). Contemporaneamente iniziarono
corse su strada con tappe sempre pi� lunghe: nel 1894 la Parigi-Brest-Parigi
(vinta dal francese Charles Terrant) e la Bordeaux-Parigi (vinta dall'inglese
Donald Mills); nel 1896 si corsero per la prima volta la Bordeaux-Parigi-Tours e
la Parigi-Roubaix mentre, ripristinate le Olimpiadi, il c. vi fu ammesso con sei
specialit�. Nel frattempo l'organizzazione sportiva del c. prese consistenza
con la costituzione delle prime federazioni nazionali. In Italia, il 6 dicembre
1885 fu costituita a Pavia l'Unione Velocipedistica Italiana (U.V.I.) la cui
denominazione fu mutata, nel 1964, in Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.).
Nel 1892 fu costituita l'International Cyclist Association (I.C.A.),
trasformatasi nel 1900 in Union Cyclist International (U.C.I.) con compiti e
strutture di massimo organo direttivo del c. mondiale. Nel 1903 si corse la pi�
appassionante delle competizioni su strada, il Tour de France, gara
internazionale a tappe; nel 1906 fu ripresa la Parigi-Bruxelles (la prima
edizione, nel 1893, fu la prima corsa a varcare i confini statali); nel 1908
furono istituiti la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro del Belgio; nel 1911 il Giro
della Catalogna e nel 1913 il Giro delle Fiandre. Numerose anche in Italia le
nuove gare, a molte delle quali arrider� notevole fortuna: nel 1903, la
Milano-Torino (ripresa dopo il 1876); nel 1905, il Giro di Lombardia; nel 1906
il Giro del Piemonte e la Milano-Modena; nel 1907, la Milano-Sanremo, il Giro
del Veneto, il Giro dell'Emilia; nel 1909 il Giro d'Italia; nel 1910 il Giro di
Romagna; nel 1911 il Giro della Campania. La I guerra mondiale rallent�, senza
interromperla, l'attivit� ciclistica europea che riprese in pieno nel 1919.
Nuove corse, poi famose, si aggiunsero a quelle gi� affermate: la Tre Valli
Varesine e la Coppa Bernocchi nel 1919; il Giro della Provincia di Reggio di
Calabria nel 1920; il Giro di Toscana nel 1923; il Giro del Lazio, il Giro
dell'Appennino (divenuto in seguito Circuito dell'Appennino) e la Parigi-Nizza
nel 1933; il Giro di Spagna nel 1935; la Freccia Vallone nel 1936. Dal 1921 per
i dilettanti e dal 1927 per i professionisti si disput� annualmente il
Campionato del mondo su strada. Durante la II guerra mondiale fu organizzata una
nuova corsa nella neutrale Svizzera: il Giro dei Quattro Cantoni (1944). Nel
dopoguerra seguirono: il Gran Premio delle Nazioni di Parigi (a cronometro) nel
1945; il Gran Premio dell'Industria e Commercio a Prato nel 1946; la
Sassari-Cagliari nel 1948; il Trofeo Baracchi (a cronometro a coppie) a Bergamo
e il Giro del Ticino nel 1949; il Gran Premio Campari di Lugano (a cronometro)
nel 1950; il Giro di Sardegna nel 1958. Le corse ricordate, comprese quelle
affermatesi fin dai primordi del c., compongono attualmente il calendario della
stagione ciclistica internazionale.
Bibliografia
R. Negri, Ciclismo nel mondo, Milano, 1955; A. Congiu, Enciclopedia del ciclismo, Milano, 1957; M. De Angelis, Il ciclismo, Roma, 1960; G. Giardini, Andare in bicicletta, Milano, 1961; V. Varale, Avventure su due ruote, Roma, 1964; G. Costa, Correre in bicicletta, Milano, 1970; R. Perego, In bicicletta, Milano, 1988.
Foto tratte dall'Enciclopedia Rizzoli
98 della Rizzoli New Media
e da Enciclopedia Encarta 98 di Microsoft Corporation
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di propriet� di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()